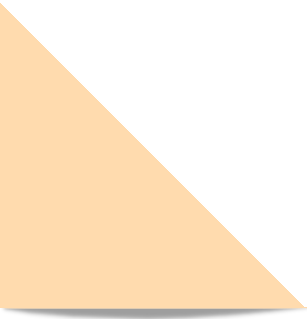|
Nel 272 a.C. Roma instaurava un
nuovo presidio militare a Locri Epizefiri. E almeno per ora
questa fu l'unica vera conseguenza che la nuova situazione,
venutasi a creare dopo la sconfitta di Pirro, causò
all'antica
polis locrese.
Roma, infatti, non pretese nulla di eccessivo dalle città
della Magna Grecia di cui da poco aveva acquisito il
controllo, dispensandole dal fornire uomini per le legioni e
chiedendo in cambio il loro supporto militare solo
attraverso la fornitura di navi da guerra nel momento in cui
essa ne avesse avuto bisogno. (Polibio, Storie, I 20, 14
e XII 5, 2; Livio, Ab Urbe Condita, XLII 48, 7)
Locri divenne, quindi, "socia navalis" di Roma, ma
mantenne ancora tutte le sue caratteristiche di città greca,
restando indipendente e continuando a battere moneta.
PRIMA GUERRA PUNICA
L'occasione nella quale Locri dovette mostrare la propria
fedeltà a Roma si ebbe molto presto.
Nel 264 a.C., infatti, la città
di Messane, minacciata dall'avanzata cartaginese in Sicilia,
chiese aiuto a Roma la quale, dopo non molto, intervenne
inviando le proprie truppe nell'isola e dando così inizio al
primo scontro con Cartagine, destinato a protrarsi fino al
241 a.C., allorquando nella battaglia navale combattutasi
presso le isole Egadi la flotta romana distrusse gran parte
della flotta nemica costringendo Cartagine alla resa.
Durante quest'arco di tempo (più di vent'anni) non è ben
chiaro il ruolo che le città greche dell'Italia meridionale
svolsero, ma si sa per certo, grazie a quanto tramandatoci
da Polibio, che sia Locri che le altre città fornirono a
Roma navi da guerra rispettando così l'impegno assunto
all'indomani della sconfitta di Pirro. (Polibio,
Storie, I 20, 7)
L'unico evento significativo di questo periodo tramandatoci
dalle fonti storiche su Locri è quello relativo
all'incursione ed al saccheggio del suo territorio operato
dalle truppe cartaginesi comandate da Amilcare Barca (dal
suo soprannome "barak", il fulmine). E', più che altro, una
brevissima annotazione che Polibio ci ha lasciato
riguardo alle operazioni delle truppe cartaginesi in terra
bruzzia durante il diciottesimo anno di guerra (247 a.C.)
che prosegue con l'indicazione dei successivi obiettivi
cartaginesi in Sicilia.
Ecco la versione integrale del
passo citato: (Polibio, Storie, I 56, 1-3).
Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι μετὰ ταῦτα στρατηγὸν καταστήσαντες
αὑτῶν Ἀμίλκαν τὸν Βάρκαν ἐπικαλούμενον, τούτῳ τὰ κατὰ
τὸν στόλον ἐνεχείρισαν· ὃς παραλαβὼν τὰς ναυτικὰς δυνάμεις
ὥρμησεν πορθήσων τὴν Ἰταλίαν. Ἔτος δ᾽ ἦν ὀκτωκαιδέκατον τῷ
πολέμῳ. Κατασύρας δὲ τὴν Λοκρίδα καὶ τὴν Βρεττιανὴν χώραν,
ἀποπλέων ἐντεῦθεν κατῆρε παντὶ τῷ στόλῳ πρὸς τὴν Πανορμῖτιν
καὶ καταλαμβάνει τὸν ἐπὶ τῆς Εἱρκτῆς λεγόμενον τόπον, ὃς
κεῖται μὲν Ἔρυκος καὶ Πανόρμου μεταξὺ πρὸς θαλάττῃ, πολὺ δέ
τι τῶν ἄλλων δοκεῖ διαφέρειν τόπων ἐπιτηδειότητι πρὸς ἀσφάλειαν
στρατοπέδων καὶ χρονισμόν.
"Dopo queste cose i
Cartaginesi, nominato loro comandante Amilcare,
detto Barca, gli affidarono le operazioni navali;
quello, preso il controllo della flotta, partì per
devastare le coste d'Italia. Era il diciottesimo
anno di guerra. Dopo aver saccheggiato il territorio
di Locri e dei Bruzzi, salpato, giunse con tutta la
flotta nel territorio di Panormo (Palermo) e si
impadronì del luogo detto Eirctè, località vicino al
mare, tra Erice e Panormo, che sembra molto più
adatto degli altri luoghi per la sicurezza dei
soldati e per una permanenza più lunga."
Il ruolo che Locri ebbe in
questa fase storica fu, dunque, molto marginale (al
contrario di quanto avverrà durante la seconda guerra
punica). Pochi anni dopo l'episodio citato la prima guerra
punica si concludeva con il risultato che Roma aveva
ampliato il proprio territorio, inglobandovi la Sicilia e
meglio attestandosi nei territori che essa già controllava.
Ma il costante aumento
dell'influenza romana incominciò a far crescere un diffuso
malcontento nelle città greche dell'Italia meridionale, le
quali mostravano, ormai, segni di insofferenza nei confronti
di Roma. E Roma stessa, in questo periodo, incomincia a
mostrare una certa diffidenza nei confronti di tali città
nelle quali, in molti casi, decise di rinforzare i presidi
già esistenti.
Con queste premesse ciò che accadrà durante la seconda
guerra punica tra le città greche e Roma sarà solo una
conseguenza di malumori cementatisi nel corso di questi
anni. |